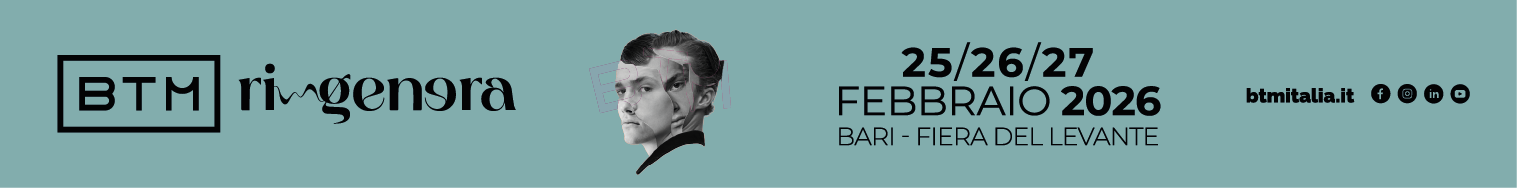Nel silenzio sospeso di tanti borghi italiani svuotati dal tempo, un’idea ha fatto parlare di sé in tutto il mondo: quella di vendere case a un euro. Un gesto simbolico, forte, che prometteva non solo un tetto a prezzo irrisorio, ma un’intera filosofia di rinascita, un’Italia che si rialza, che si reinventa partendo dalle sue ferite: i paesi abbandonati, le case murate, i bambini mai nati, gli anziani rimasti a presidiare i ricordi.
Il progetto delle “case a un euro” nasce ufficialmente alla fine degli anni Duemila, ma è solo nel decennio successivo che si trasforma in fenomeno mediatico globale, telegiornali americani, blog di viaggiatori australiani, influencer giapponesi, riviste tedesche, tutti affascinati dall’idea di comprare una casa in Italia al prezzo simbolico di una moneta da un euro. Una trovata di marketing territoriale tanto semplice quanto potente ma, come spesso accade, la realtà è più complessa della suggestione.
A distanza di anni, la domanda è lecita: perché il progetto non è mai decollato davvero, se non in pochissime eccezioni? Dove si è inceppato quel sogno così fotogenico, così appetibile per i giornali e così apparentemente vantaggioso per i territori coinvolti?
La risposta, come sempre in Italia, sta nei dettagli e nei dettagli, spesso, si nasconde il diavolo.
L’idea in sé è affascinante: il comune mette a disposizione immobili disabitati o abbandonati, ottenuti attraverso rinunce ereditarie, donazioni, oppure tramite accordi con proprietari che non vogliono più pagare IMU o manutenzioni. Il prezzo simbolico serve a sancire un patto: l’acquirente deve impegnarsi a ristrutturare l’immobile entro un termine stabilito (di solito due o tre anni) e, in alcuni casi, a risiedervi stabilmente o ad aprirvi un’attività. Tuttavia, quello che sulla carta sembra un accordo win-win dove il borgo recupera e l’acquirente ottiene una casa, nella pratica si scontra con ostacoli che pochi immaginano, soprattutto tra chi arriva da oltre confine con il sogno dell’Italia da cartolina.
Innanzitutto, la burocrazia! Avviare un progetto di ristrutturazione in Italia non è mai banale, tra vincoli paesaggistici, norme antisismiche, piani regolatori spesso obsoleti e una giungla di permessi edilizi, anche il più determinato degli stranieri si trova facilmente disorientato. In molti comuni non esiste un servizio di assistenza dedicato, né una regia tecnica che accompagni passo-passo l’acquirente. Chi compra si ritrova da solo, alle prese con geometri, ingegneri, moduli in italiano, richieste di documenti, scadenze poco chiare. Il sogno si trasforma in fatica, e spesso si spegne ancora prima di cominciare.
Poi ci sono i costi reali, che sono ben diversi dall’euro simbolico! Ristrutturare una casa antica in un centro storico può facilmente costare decine di migliaia di euro. I lavori devono rispettare vincoli stilistici, usare materiali specifici, e molto spesso richiedono interventi strutturali complessi. A questi costi si aggiungono quelli notarili, catastali, assicurativi, e in alcuni casi una fideiussione bancaria da depositare a garanzia dell’impegno.
Ma il vero nodo, quello che molti borghi non hanno voluto affrontare, è che una casa non basta per far tornare la vita. L’errore strutturale del progetto è stato pensare che bastasse vendere edifici per ripopolare comunità ma le persone non si trasferiscono solo per un tetto, lo fanno per una rete di servizi, per opportunità lavorative, per infrastrutture, per scuola e sanità, per mobilità e connessioni digitali. In molti dei paesi che hanno avviato il progetto, questi elementi sono mancati, le scuole erano già chiuse, i negozi svaniti, le strade impervie, la rete internet assente. Come si può pensare di trattenere una famiglia giovane, un imprenditore, un artista, se tutto attorno è vuoto o inaccessibile?
Non va dimenticato poi che molte di queste case sono ruderi veri e propri, non abitazioni semplicemente trascurate con tetti crollati, mura compromesse, impianti inesistenti. Case che nessuno ha più abitato da mezzo secolo e dunque la loro ristrutturazione non è un intervento cosmetico ma un’opera di ricostruzione profonda, complessa, costosa, spesso proibitiva per chi pensava di vivere un’avventura romantica tra le colline.
E infine, c’è l’elemento umano e organizzativo: la gestione locale. In molti comuni, pur animati da buone intenzioni, è mancata una visione strategica, una professionalità adeguata, una capacità di fare sistema. L’iniziativa è stata trattata come un’operazione spot, buona per far parlare del paese sui giornali, ma non inserita in un disegno più ampio di rigenerazione territoriale, non si è pensato a creare reti di imprese locali pronte a supportare le ristrutturazioni, non si è costruita una proposta integrata fatta di accoglienza, turismo, coworking, attività culturali. Il risultato è che molti progetti si sono arenati, lasciando dietro di sé solo qualche titolo e poche case davvero recuperate.
Ci sono però alcune eccezioni virtuose che mostrano come il progetto possa funzionare, se accompagnato da una regia intelligente come Gangi in Sicilia, Sambuca, Ollolai in Sardegna. Borghi che hanno saputo abbinare la vendita delle case a un euro a strategie di promozione turistica, eventi, incentivi, reti professionali, investimenti paralleli. Dove c’è stata una visione e un’assistenza reale per chi acquistava, sono arrivati risultati ma si tratta ancora di mosche bianche in un panorama frammentato e spesso improvvisato.
Forse è giunto il momento di cambiare paradigma, non pensare più alla “casa a un euro” come a un prodotto da vendere, ma al borgo come progetto di vita da costruire, offrire a chi arriva non solo un immobile, ma un’opportunità di lavoro, di comunità, di creatività. Pensare a modelli di abitare sostenibile, dove la casa è solo una parte di un ecosistema fatto di relazioni, servizi, bellezza e funzionalità.
Perché la vera sfida non è vendere case, ma ricostruire luoghi dove valga la pena abitare, con tutto ciò che questo comporta e finché non si affronterà questa complessità con competenza, visione e coraggio, l’Italia continuerà a vendere sogni a un euro ma a un prezzo, spesso, troppo alto da pagare per chi ci crede davvero.