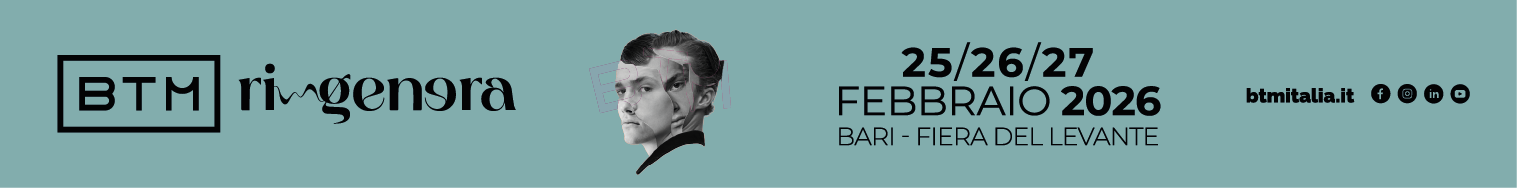L’Italia occupa stabilmente una posizione di vertice nell’immaginario turistico mondiale e rappresenta per percezione qualitativa,...
Editoriali e Opinioni
Il progressivo calo delle iscrizioni agli istituti alberghieri non è un incidente di percorso né...
La geografia del traffico aereo italiano sta cambiando in modo rapido e selettivo. Nuove basi...
Nel dibattito sul management alberghiero si tende ancora troppo spesso a parlare di competenze, ruoli...
Tra le proposte lanciate la scorsa settimana durante il Forum Internazionale del Turismo di Milano...
Il cambiamento nel turismo raramente si manifesta come una frattura netta, riconoscibile, immediatamente leggibile. Non...
Il turismo rappresenta oggi uno dei comparti a maggiore incidenza sull’economia nazionale, sia in termini...
Ogni inizio d’anno l’industria dell’hospitality sembra attraversare lo stesso rito collettivo: la caccia ai trend....
C’è una frase che torna spesso nelle riunioni di albergatori, nei convegni di settore, nelle...
C’è un momento preciso in cui il turismo smette di vendere luoghi e inizia a...
La parola turistificazione è entrata nel nostro vocabolario quasi in punta di piedi, come spesso accade ai...