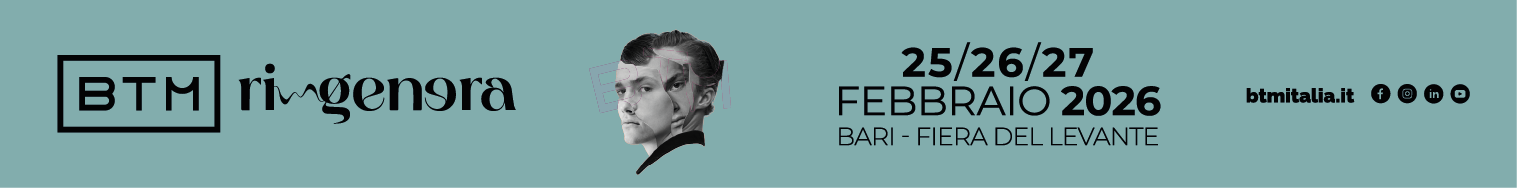L’estate 2025 si profila come la stagione della riscoperta domestica e del turismo interno. A confermarlo è il nuovo Behavior Change Report di YouGov, che fotografa un’Italia sempre più attenta al portafoglio, ma non per questo disposta a rinunciare completamente al piacere delle vacanze. Secondo l’indagine, il 58% dei consumatori italiani ha però scelto di trascorrere l’estate in patria, ben oltre la media europea del 42%. A guidare la decisione è soprattutto la prudenza economica: un italiano su quattro (25%) dichiara di voler limitare le spese, con un 38% che intende risparmiare di più rispetto al 2024, mentre il 7% rinuncerà del tutto a viaggiare.
Nel nuovo scenario turistico guadagna quindi terreno anche la “staycation”, concetto di vacanza trascorsa a casa o nei dintorni, nato negli Stati Uniti e diffusosi durante la pandemia. Quest’anno coinvolgerebbe un italiano su quattro, spinto dal desiderio di vivere una pausa rilassante senza stress e senza spostamenti. Il 32% degli intervistati afferma di voler creare un’atmosfera vacanziera nel proprio ambiente domestico, mentre il 30% punta sulla sperimentazione culinaria e il 28% su grigliate e momenti conviviali con amici e familiari.
Un concetto da chiarire: la staycation non è una vacanza
Pur raccontata sui media generalisti come alternativa legittima al viaggio, in questa sede dobbiamo fare presente che la staycation rappresenta un compromesso più che una vera vacanza. Il concetto stesso di vacanza implica una sospensione della routine, un distacco fisico e mentale dall’ambiente quotidiano e un cambiamento di contesto, anche minimo, che favorisca il riposo e il rinnovamento interiore. Trascorrere il tempo libero tra le mura domestiche – seppur con grigliate, libri e serie tv – non equivale a un’esperienza di viaggio, né offre la stessa qualità di rigenerazione psico-fisica. Altrimenti anche la pandemia l’avremmo dovuta chiamare vacanza, ma non mi pare né siamo usciti rigenerato. E dobbiamo ricordare anche che una gita fuori porta, senza pernottamento, non rientra neanche tra le statistiche del turismo che si basano, essenzialmente, sulle notti trascorse in hotel e altre strutture ricettive.
La crisi del ceto medio e il rischio che la vacanza torni elitaria
In un momento storico in cui il benessere mentale è sempre più centrale, ridurre quindi la vacanza a una semplice pausa “casalinga” rischia di normalizzare la rinuncia, presentandola come scelta creativa o sostenibile. Ma un conto è valorizzare il territorio, altro è non poter partire per necessità economiche e chiamarla ‘vacanza’. Forse dovremmo chiamare le cose col proprio nome: in Italia siamo in una fase di crisi economica del ceto medio, con stipendi stagnanti, costo della vita in aumento e viaggi ritornati proibitivi per molti, nonostante opzioni a basso budget che un tempo neanche esistevano: non è un caso che il 58,6% degli intervistati da YouGov indichi il rapporto qualità prezzo come il criterio principale di scelta. In questo contesto, in cui si parla a sproposito di overtourism per pochissime località in cui non riusciamo a gestire i flussi, rischiamo che la vacanza torni a essere una scelta elitaria, col paradosso che chi lavora nel turismo è tra i primi a non poter viaggiare, sia perché lavora mentre gli altri si divertono, sia perché non può permetterselo. Oltre un secolo fa Henry Ford pagava gli operai perché potessero permettersi le auto che stavano costruendo. Oggi per rilanciare il turismo penso dovremmo fare in modo che chi ci lavora possa permettersi le esperienze che fa vivere agli altri.
In questo contesto, il ritorno al turismo domestico deve farci riflettere sul nostro rapporto con il tempo libero, il territorio e il lavoro. Ma perché questa riscoperta non si traduca in rassegnazione e “staycation”, serve una nuova narrazione collettiva, capace di rimettere al centro il valore dell’accoglienza, della qualità e della dignità professionale.
Sono stato in Giappone e tra templi millenari, innovazione urbana e un’efficienza sorprendente, ciò che mi ha colpito di più è stato l’entusiasmo dei lavoratori del turismo: uomini e donne di ogni età che, anche sotto il sole torrido di Tokyo e Osaka, accolgono con un sorriso instancabile, con orgoglio e con quella cura dei dettagli che trasforma un semplice servizio in esperienza.
Una lezione che non dimenticherò e che mi porta a pensare che se nel nostro Paese, avessimo almeno la metà di quella passione, quell’energia, di quel senso di appartenenza, le cose andrebbero molto meglio. Ma l’entusiasmo non lo crei per contratto, la motivazione non arriva se non viene alimentata con delle gratificazioni.
Se vogliamo davvero uscire dalla crisi del ceto medio e costruire un’Italia più inclusiva e resiliente, dobbiamo partire da qui: restituendo valore al lavoro, puntando sulla formazione, sostenendo le imprese che innovano e i territori che investono nell’autenticità, permettere anche alle aziende del turismo, per loro natura stagionali, di poter garantire un compenso adeguato a chi ci lavora e crea valore per gli ospiti. Perché il benessere non si misura solo in metri percorsi o soldi spesi, come pensa qualche imprenditore del turismo, gli stessi che poi si lamentano di non trovare lavoratori offrendo paghe da fame e turni impossibili. Si misura invece nella qualità delle relazioni, nella fiducia nel futuro, e nella capacità – anche italiana – di trasformare ogni viaggio, anche a pochi chilometri da casa, in un momento che vale la pena ricordare.
E questo lo puoi fare solo con personale motivato ed equamente ricompensato: perché un lavoratore sereno, che può permettersi una vacanza, che sente di avere un ruolo riconosciuto e un futuro possibile, è anche un lavoratore più motivato, attento, generoso: nel turismo come in ogni altro settore. Ritrovare dignità, entusiasmo e prospettive per il ceto medio non è solo una questione sociale, ma un investimento strutturale per un’Italia che vuole davvero ripartire.