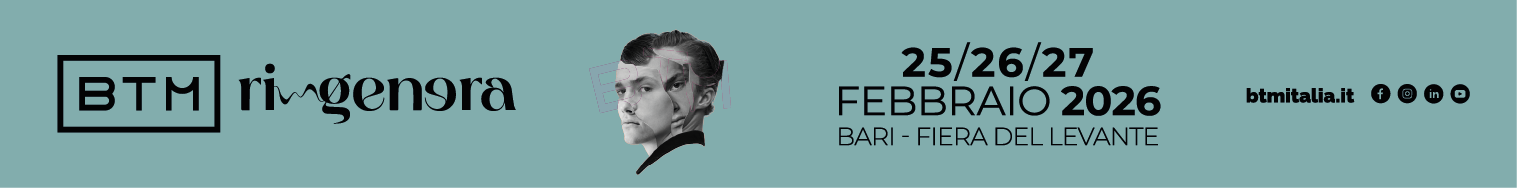Ho scelto di pubblicare questa riflessione perché il tema tocca da vicino anche il comparto turistico e alberghiero. In questo settore, infatti, lavorano moltissimi professionisti che operano con partita IVA in regime forfettario: guide turistiche, accompagnatori, interpreti, fotografi, consulenti di marketing e comunicazione, formatori specializzati, organizzatori di eventi, agenzie incoming di piccole dimensioni, accompagnatori naturalistici, autisti NCC e perfino piccole strutture extralberghiere gestite in forma familiare. Tutte figure fondamentali per il buon funzionamento della filiera turistica, ma spesso schiacciate da un sistema fiscale che non dialoga con la realtà del loro lavoro quotidiano, fatto di stagionalità, incassi variabili e margini spesso sottili.
Il regime forfettario, introdotto in Italia con l’obiettivo di semplificare la vita ai piccoli imprenditori e ai professionisti, è stato salutato come una conquista di civiltà fiscale. Aliquota chiara, riduzione della burocrazia, semplificazione contabile: questi i tre pilastri su cui si è retto e grazie ai quali centinaia di migliaia di partite IVA hanno trovato una via più sostenibile per avviare e gestire la propria attività tuttavia, dietro questa apparente linearità si cela una contraddizione che molti conoscono bene: il calendario fiscale.
Il sistema attuale, infatti, non prevede che il forfettario paghi le imposte in modo progressivo e diluito seguendo il ritmo del proprio fatturato, al contrario, i versamenti si concentrano in due scadenze principali, a giugno e novembre, con saldo e acconto, una modalità che nasce da una logica tributaria antica, legata a modelli di riscossione ormai superati e che produce squilibri sempre più insostenibili in un contesto economico dove la liquidità e la capacità di pianificazione sono vitali.
Chi è in regime forfettario lo sa bene: il primo anno si paga poco o nulla, ma già dal secondo arriva la “mazzata”, perché al saldo si somma l’acconto sull’anno successivo, così può capitare di trovarsi a versare cifre spropositate, anche superiori al reddito realmente incassato nei mesi precedenti, con la conseguenza che non pochi professionisti finiscono in difficoltà o costretti a rateizzare. Nel turismo questo problema si amplifica: pensiamo a una guida turistica che concentra i guadagni in primavera ed estate e si trova a dover pagare imposte elevate in mesi in cui le entrate sono quasi azzerate non è un caso che uno dei problemi più comuni tra i piccoli autonomi sia la gestione dell’ansia legata al dover “tenere da parte” un gruzzolo per il fisco, senza però avere un vero strumento che li aiuti a farlo in modo ordinato e automatico.
A questo punto la domanda è naturale: perché non introdurre un sistema di pagamento mensile o bimestrale, che segua il principio “paghi quando guadagni”? Non sarebbe più logico, più equo e più in linea con la realtà quotidiana delle partite IVA?
Il paragone con il modello anglosassone è illuminante. Nel Regno Unito, e in altri paesi che adottano il sistema Pay As You Earn (PAYE), il concetto è semplice, le imposte vengono trattenute mese per mese, contestualmente alla maturazione del reddito. Un lavoratore dipendente riceve il netto in busta paga già al netto delle tasse mentre un autonomo versa contributi e imposte in maniera progressiva, calcolati sui ricavi reali e non su previsioni. È un meccanismo che garantisce una gestione equilibrata, riduce il rischio di insolvenze e soprattutto rende trasparente il rapporto tra reddito e fisco.
Traslare questo principio nel contesto italiano dei forfettari non è un’utopia, anzi, oggi esistono già gli strumenti tecnici per renderlo possibile. Con l’obbligo della fatturazione elettronica e il passaggio attraverso lo SDI (Sistema di Interscambio), ogni singola fattura emessa da un professionista forfettario viene registrata in tempo reale dunque non solo l’Agenzia delle Entrate, ma anche i commercialisti hanno accesso a questi dati, con la possibilità di monitorare mese per mese l’andamento del fatturato.
Questo significa che il problema della verifica non esiste più e se fino a qualche anno fa si poteva obiettare che l’amministrazione non aveva strumenti rapidi per conoscere i ricavi effettivi di un forfettario, oggi questa scusa cade. Le fatture sono digitali, tracciate, consultabili e a maggior ragione considerando che il regime forfettario prevede un tetto massimo di 85.000 euro annui di fatturato, parliamo di numeri contenuti, facili da gestire e da verificare.
Immaginiamo dunque un sistema PAYE applicato ai forfettari: ogni mese o bimestrale, sulla base delle fatture emesse e incassate, viene calcolata la quota di imposta da versare. Se a gennaio fatturo 3.000 euro, pago il 15% (o il 5% se sono nei primi anni di attività) su quel valore. Se a febbraio fatturo meno, ad esempio 1.200 euro, pago la percentuale corrispondente, il tutto con un versamento snello, magari automatizzato tramite F24 digitale.
Certo, resta il nodo dei tempi di incasso. In Italia, salvo accordi specifici, il termine legale per pagare una fattura è di 30 giorni dal ricevimento della merce o del servizio, tuttavia, chi lavora nel turismo sa bene che può capitare che una o più fatture vengano saldate oltre il mese, per ragioni legate alla stagionalità o ai ritardi degli operatori. In questi casi il rischio è evidente, dover comunque versare imposte su somme non ancora effettivamente incassate ma anche davanti a questa criticità, il principio di una tassazione dilazionata e “morbida” resterebbe valido, perché distribuire i pagamenti in maniera progressiva è comunque più sostenibile che concentrare tutto in due maxi-scadenze annuali.
Quali sarebbero i vantaggi?
Prima di tutto la sostenibilità psicologica ed economica. Invece di vivere con l’incubo delle scadenze estive e autunnali, il professionista saprebbe di dover affrontare un impegno costante, diluito e proporzionato al proprio fatturato. Niente più “mazzate” da migliaia di euro in una sola volta, ma una gestione lineare della liquidità. In secondo luogo, ci sarebbe una maggiore certezza gestionale: il forfettario potrebbe programmare entrate e uscite sapendo che ogni mese dovrà accantonare una cifra precisa. Questo, a sua volta, rafforzerebbe la capacità di pianificazione a medio termine e ridurrebbe i casi di insolvenza o di evasione involontaria.
Un sistema mensile porterebbe anche benefici indiretti. Innanzitutto, migliorerebbe il rapporto tra Stato e contribuenti infatti una percezione di un fisco che accompagna, anziché punire, renderebbe più sereno e collaborativo il clima generale. Inoltre, diluendo gli incassi erariali lungo tutto l’anno, lo Stato stesso avrebbe flussi di cassa più regolari e prevedibili.
Naturalmente, ogni proposta di riforma incontra ostacoli. I primi riguardano la burocrazia: passare da un sistema di acconti e saldi a uno mensile/bimestrale richiederebbe un cambio radicale nelle procedure, nei software gestionali e nei rapporti con i commercialisti, c’è poi la questione dei costi. Un controllo mensile o bimestrale, anziché annuale, potrebbe tradursi in un aggravio di lavoro per gli studi professionali ma anche questo argomento perde di peso se si considera che oggi i commercialisti hanno accesso diretto allo SDI e possono monitorare i flussi in modo quasi automatico.
E qui si apre un ulteriore spunto: perché non lasciare al contribuente la scelta?
Chi ha un’attività con ricavi costanti durante l’anno potrebbe continuare a preferire la modalità classica di saldo e acconto, chi invece lavora in settori stagionali come il turismo, l’agricoltura o gli eventi, dove i guadagni sono concentrati in alcuni mesi, avrebbe tutto l’interesse a optare per un sistema PAYE che distribuisca il carico fiscale in maniera più equa e proporzionata ai flussi reali di cassa.
Il vero ostacolo, più che tecnico, è culturale. L’Italia resta legata a un modello fiscale novecentesco, che ragiona in termini di previsioni, acconti e saldi ma è una resistenza che prima o poi dovrà essere superata, perché il mondo del lavoro autonomo sta cambiando e non può più permettersi di subire un sistema che penalizza proprio sul fronte più delicato: la gestione della liquidità.
In conclusione, la questione non è se un sistema PAYE per i forfettari sia possibile, è già tecnicamente attuabile, grazie alla fatturazione elettronica e al tetto massimo di ricavi che rende i controlli gestibili, la vera domanda è quando e con quale coraggio politico si deciderà di affrontare il cambiamento. Perché se davvero il regime forfettario vuole essere un sostegno e non solo un’etichetta, deve garantire non solo aliquote agevolate e meno burocrazia, ma anche un sistema di pagamento equo, sostenibile e moderno.
Un sistema che non lasci i piccoli imprenditori del turismo — così come di altri settori — a temere il calendario, ma che li accompagni mese per mese nella loro crescita.